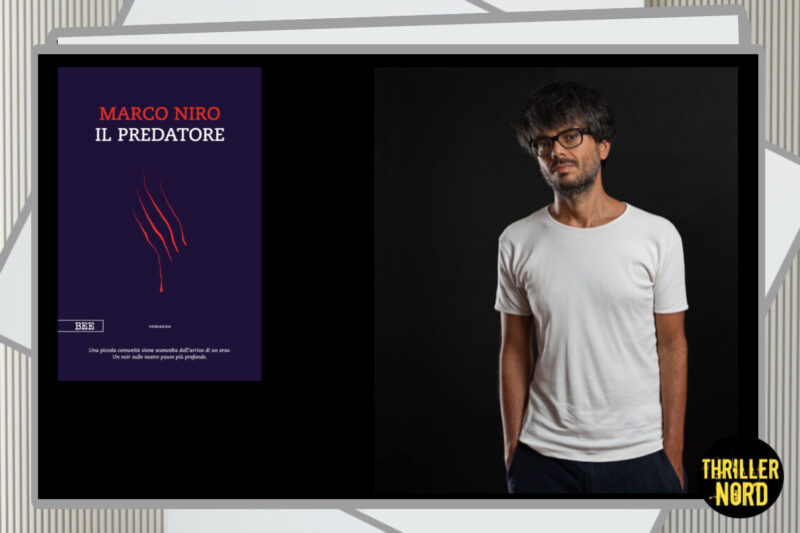A tu per tu con l’autore
Come mai hai deciso di ambientare il tuo romanzo in montagna e, soprattutto, perché hai deciso di scegliere proprio gli orsi quali coprotagonisti della storia?
Ho deciso di scrivere un romanzo ambientato in montagna forse soprattutto per il fatto che in montagna ci vivo da quasi vent’anni ma le mie radici affondano in pianura, e quindi ambientarci un romanzo è stato un modo per sancire in via definitiva la mia cittadinanza nelle terre alte. Anche se non ne ho cantato esattamente le lodi… Amo la montagna, la sua bellezza aspra, ma disapprovo il modello di sviluppo che in montagna, specialmente sulle Alpi, è stato adottato e spinto nei decenni passati, e ancora oggi resta in auge: il modello “luna park”, degli impianti sciistici che vanno avanti imperterriti nonostante la neve sia ormai un fatto raro, dei cannoni che sparano neve artificiale anche quando tutto intorno è siccità, dei rifugi presi d’assalto da gente in infradito che pensa di trovarsi all’aperitivo sui Navigli, delle code o addirittura delle gare di auto sui passi, degli orsi che sono buoni finché hanno le sembianze di Yoghi e Bubu e servono ad acchiappare i turisti, ma diventano cattivi, da deportare o sopprimere in blocco, non appena si comportano da orsi. Vedo gli orsi come un simbolo, ed è per questo che ho messo al centro del mio romanzo il rapporto tra noi e loro. Simbolo di biodiversità, innanzitutto: un ambiente che consenta agli orsi di riprodursi è un ambiente sano. Ma anche simbolo dei limiti che la natura ci impone: dove ci sono gli orsi, alcune cose non si possono fare. Solo che noi non siamo più abituati ad avere dei limiti. Non sto dicendo che un orso problematico vada lasciato libero di fare danni, ovviamente, sto dicendo che deve cambiare completamente il nostro approccio a ciò che è diverso da noi, a ciò che ci costringe a fare delle rinunce. Dobbiamo capire quando è il caso di accettare i limiti. La narrativa in questo senso può aiutare. Abbiamo bisogno di romanzi che diano più spazio all’elemento “non umano”, che ci aiutino a sintonizzarci con esso, a conoscerlo, ad accoglierlo, che spostino il nostro punto di vista antropocentrico, che ci spingano a vederci per quello che siamo: una specie fra le altre, non superiore alle altre. Penso che in questo modo i narratori possano dare un contributo importante al tentativo di fronteggiare la crisi ecologica in corso, una sfida oggi decisiva e non più rinviabile.

A quale personaggio del romanzo sei più legato e quale tra questi ti ha dato maggiore soddisfazione nel costruirlo?
Indubbiamente il personaggio di Diego. C’è anche qualcosa di autobiografico in questo tredicenne insicuro e incompiuto, perennemente afflitto da un senso di inadeguatezza, che legge tanto, legge Thoreau e al tempo stesso sa di non avere il coraggio di fare come lui, mollare tutto e andare a vivere nei boschi, quei boschi da cui si sente attratto, perché solo lì riesce a sentirsi leggero e a respirare, anche se poi passa la maggior parte del tempo chiuso nella sua camera, al riparo da rischi e imprevisti, perché la vita gli fa troppa paura per viverla fino in fondo. La storia di tanti, a ben vedere. Che però, nel romanzo, prende una piega inaspettata, imprevedibile, e diventa la storia di uno soltanto.
Nel tuo romanzo vi sono tantissimi ingredienti che possono essere ricondotti a generi letterari molto differenti tra loro. Quali sono gli scrittori che preferisci e che leggi con molto piacere?
Ho voluto ricorrere agli stilemi del genere, di più generi, perché penso che la scrittura di genere possa essere straordinariamente capace di portare all’attenzione del pubblico certi temi, diciamo d’impegno se non proprio di militanza civile, continuando però a risultare accattivante e coinvolgente, a inchiodare il lettore alla pagina. In altre parole, attraverso il genere si può parlare di antropocentrismo e crisi ecologica anche a chi prima di tutto abbia voglia, legittimamente, d’immergersi in una storia noir, thriller, gialla. Credo che sia tempo di superare definitivamente la distinzione pretestuosa tra letteratura impegnata e letteratura di genere. Tra gli scrittori che meglio ci sono riusciti, in Italia, mi vengono in mente Massimo Carlotto col noir e i Wu Ming con la storia e la fantascienza. Sul piano internazionale, ad aver fatto la medesima scelta ci sono per esempio due grandi come Margaret Atwood e Roberto Bolaño. Nello stesso solco, due romanzi che ho recentemente letto e apprezzato sono “Il tarlo” di Layla Martinez e “La ricreazione è finita” di Dario Ferrari. Voglio infine menzionare un altro gigante, citato apertamente anche ne “Il predatore”, benché non sia normalmente pensato come scrittore di genere: José Saramago, il quale in quel romanzo straordinario e sfacciatamente politico che è “Saggio sulla lucidità” compie una straordinaria rivisitazione del genere poliziesco in chiave parodistica e grottesca.
Qual è il momento della giornata (se esiste) in cui preferisci scrivere?
Se intendi quale orario, qualsiasi. Credo di aver scritto a ogni ora del giorno, mi manca solo l’alba, ma solo perché crollo sempre sulla tastiera prima che spunti il sole. Battute a parte, più che un’ora preferita ho la mia situazione preferita, anzi imprescindibile: quella dove c’è assoluto silenzio. Mi spiace deludere chi ha in mente lo scrittore romanticamente o maledettamente intento a buttare giù frasi al tavolino di un bar affollato, fumoso e caotico, ma io, molto più modestamente, sono un po’ come Diego: ho bisogno di starmene al chiuso del mio studio, e di una concentrazione totale. La cosa curiosa è che questo vale solo per i romanzi. Nel caso dei racconti sono più malleabile e tollerante: il bar affollato, fumoso e caotico continua a essere off limits, però quando scrivo storie brevi riesco ad accettare, per esempio, il gatto che salta sulla tastiera o qualcuno che parla al telefono un paio di stanze più in là. Purché non sbraiti, s’intende.
A cura di Salvatore Gusinu
Acquista su Amazon.it: