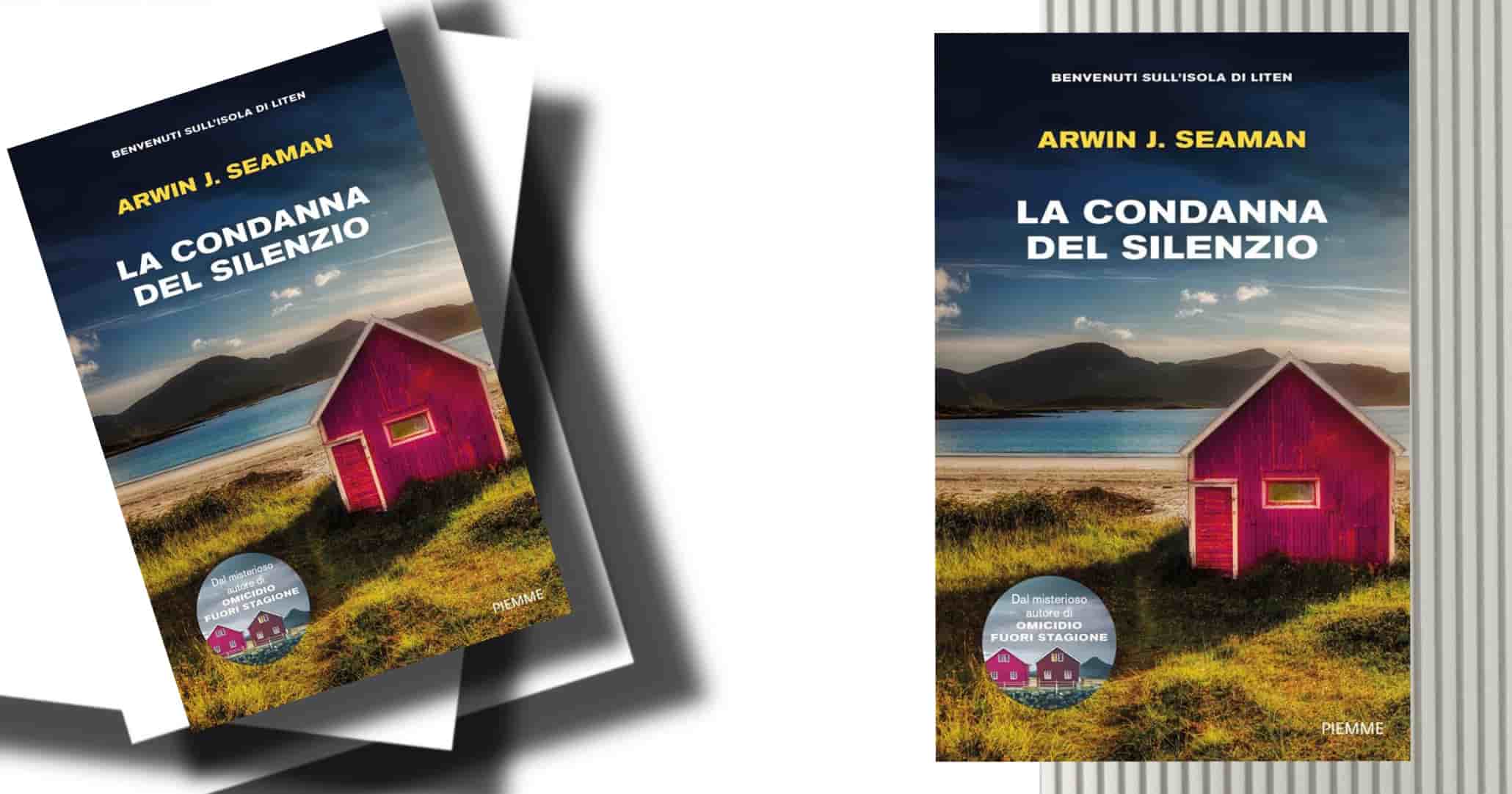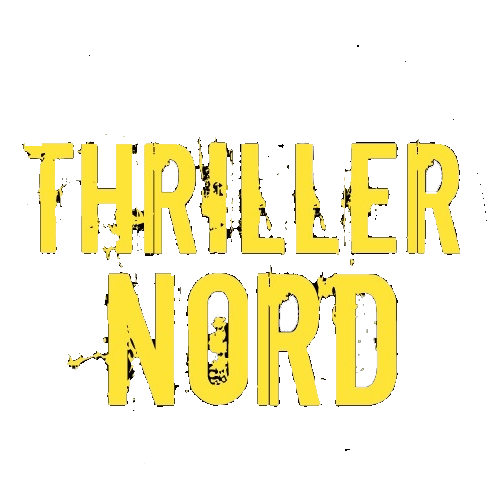A tu per tu con l’autore
Partiamo dalla firma in copertina: Arwin J. Seaman. Non il Suo vero nome, ma un nom de plume. Inutile dire che la curiosità verso la Sua vera identità è altissima, e ben consapevoli che non possa essere svelata, volevamo però chiederLe quello che ci può dire circa le ragioni di scrivere sotto pseudonimo e le suggestioni che l’hanno mossa a scegliere proprio questo pseudonimo … Seaman …marinaio, uomo di mare …adattissimo per Liten …
La scelta del “nom de plume” ha, in realtà, una base musicale. Volevo un nome che “suonasse” bene, dato che, ahimè, ciascuno di noi si ritrova nome e cognome riservati dal destino, e non sempre questi sono piacevoli.
Arwin è un nome etereo, di vago sentore celtico, quanto alla felice coincidenza del cognome col significato, è stata una casualità di cui mi sono accorto in seconda battuta. Perciò, di nuovo, il destino ha giocato un proprio ruolo. In merito alle ragioni della mia scelta, ho scritto sempre storie molto radicate nella realtà del nostro paese. Inventare un intero microcosmo, in un ambiente tanto lontano, mi consentiva un passo diverso e anche l’uso di una certa “grazia” nei confronti dei meccanismi investigativi. Era inoltre un esperimento, un azzardo, e io amo gli azzardi.
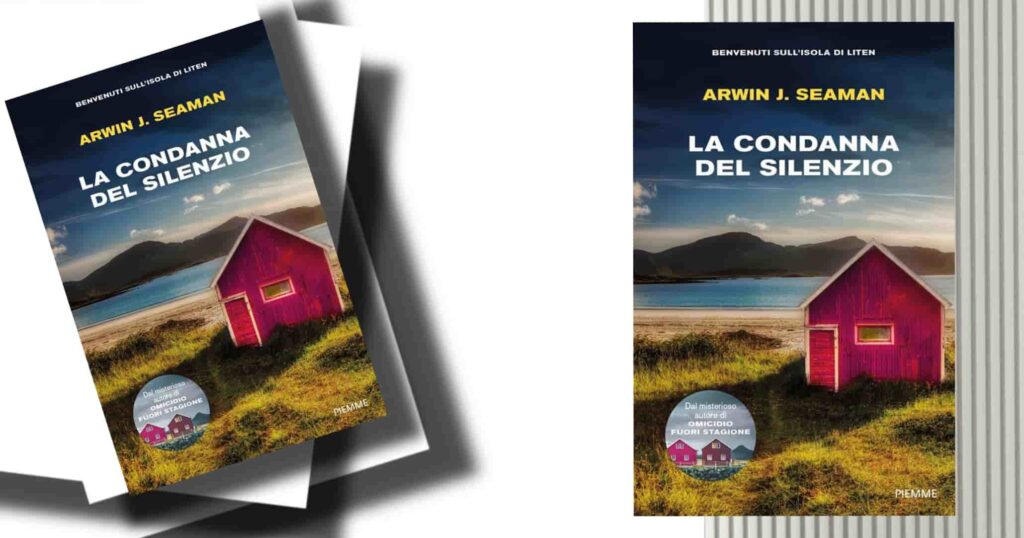
I personaggi sono parecchi: Annelie Lindahl e Kaj Bak, la figlia del commissario Owe, Malin Dahlberg, e loro, gli Andersson. C’è poi Henning Olsson, definito il “piccolo principe” della scientifica per la sua abilità, che in un modo o nell’altro è legato all’isola e non riesce a farne a meno. Come sono nate queste figure così particolari, che ha saputo tratteggiare in modo superlativo, arricchendole di caratteristiche umane e credibili? Fra loro, quale potrebbe arrivare a definire il Suo preferito?
Rispondo senza indugio all’ultimo quesito: mi identifico profondamente in Owe Dahlberg. Immagino che si evinca dalla benevolenza con cui l’ho sempre trattato, sebbene sia una figura che si è spesso confrontata con il dolore.
Gli altri cinque co-protagonisti, che a turno hanno assunto o assumeranno il ruolo principale in uno dei sei romanzi, sono nati con grezze definizioni insieme al concepimento della saga. Malin Dahlberg è stata la prima su cui ho lavorato, poiché è la sola che nell’arco di sei anni (quelli attraverso i quali si sviluppa l’arco narrativo di Liten) cresce in maniera drastica, passando da quindici a ventun anni, con una trasformazione netta. Gli altri sono figli della loro cosiddetta “backstory”, che solo nei casi di Annelie e Owe mi era chiara sin dall’inizio. Su Carola, Henning e Kaj ho lavorato invece man mano che la lunga linea orizzontale si sviluppava.
Tutt’altro discorso per il clan Andersson. Nati inizialmente come cornice al vecchio Theo nel primo volume, hanno poi preso corpo e spazio. Mi è sembrato interessante questo gruppo di persone tutte simili e tutte unite, con evidenti atteggiamenti di chiusura verso l’esterno, eppure parzialmente padrone dell’isola. Non avevo, tuttavia, immaginato che potessero riscuotere tanto successo.
C’è poi un altro gruppetto di signore, dal ruolo ben definito che spicca nei Suoi romanzi: Hedda, Selma, Marta, Carola, Tuva e Tilda. Stiamo parlando “dell’esercito di Malin”, che a chiamarlo così dà sicuramente un’impressione marziale, ma che invece ricopre un ruolo importante nei diversi aspetti della vita di questa giovane e complicata ragazza, dalla morte della madre, tanto da poterla definire una sorta di sua eredità. Vuole parlarcene?
L’esercito di Malin è un elemento ambivalente. Visto da un lato, ovvero dall’ottica della madre scomparsa, è un puntello per la figlia: cinque punti di riferimento che, uniti, tentano di sostituire la figura materna. Ma, visto dall’ottica del padre, sono barriere tra lui e la figlia. La premura di una donna, prossima alla morte, si è trasformata in un atto vessatorio nei confronti del marito. Di conseguenza, come spesso accade nel piccolo universo di Liten, la compianta Henna Dahlberg può essere percepita come buona o come cattiva, donna di luce o donna di ombre. Le cinque figure che proteggono Malin, a differenza sua, sono invece percepite positivamente, poiché tentano, ciascuna a proprio modo, di assolvere un dovere difficile. Di fatto, la contrapposizione tra Owe e l’esercito crea una frattura, una crepa che, libro dopo libro, si allarga.
E cosa dire dell’altra grande signora protagonista delle storie, Liten stessa? Affrontandola come personaggio puro, cosa ci direbbe del suo carattere, della sua indole? A cosa si è ispirato per creare un’ambientazione così suggestiva e allo stesso tempo così vividamente reale?
Il nostro meraviglioso paese è pieno di “isole”. Paesini arroccati tra le montagne, centri abitati lontani da tutto o da tutti, comunità che per decenni hanno dovuto lottare per la bonifica di un territorio e che, quindi, ad esso si aggrappano con tutte le loro forze. La terra, nella letteratura italiana, è sempre un elemento fondamentale. Liten è la terra che unisce e che imprigiona, è la realtà che appare insoddisfacente a chi ci vive, salvo poi rimpiangerla quando la si perde. La mia isola immaginaria è un simbolo della Natura, madre e matrigna, sviluppatasi intorno a un vulcano, elemento di distruzione, circondata da acque contese, contesa essa stessa. Ama i suoi figli ma concede loro poco, severa, solitaria, forse in cerca di un riscatto. Indubbiamente il personaggio più affascinante.
Uno dei luoghi che intrigano maggiormente, è sicuramente l’unità abitativa del clan, degli Andersson che, nel secondo capitolo della serie, “Un giorno di calma apparente”, per motivi affini alla storia, emerge in tutta la sua maestosità, presentandosi e mettendosi a nudo con il lettore. Leggendo ci si immagina questo “labirinto” che andava a collegare ogni struttura con la successiva. Una ramificazione di corridoi e pareti infinita, che permette di raggiungere qualsiasi luogo della casa e, anzi, qualsiasi casa della famiglia. Come è arrivato a un progetto del genere, che peraltro il Suo talento narrativo riesce a restituire anche visivamente, come una fotografia in 3d?
Man mano che emergeva la mia idea di questa singolare famiglia, ho sempre più spesso pensato al Leviatano, un enorme mostro ritratto con molteplici aspetti e dagli ancor più diversi significati. L’abitazione di questo mostro, composto da ventotto entità, non poteva che essere un interminabile cunicolo, una tana labirintica dove solo lui sapesse orientarsi. Gli Andersson sono una famiglia contadina, di quelle che, un tempo, si dividevano la stessa casa, mescolando le stanze, smistandosi come capitava nei letti, chi di piedi e chi di testa. Concettualmente, sebbene ogni nucleo famigliare abbia il proprio spazio, le porte non si chiudono mai, e, come in un formicaio, ciascuno può passare da un ambiente all’altro senza alcun permesso. La condivisione, portata all’estremo, è una caratteristica fondamentale di questa famiglia.
Ognuno dei romanzi è incentrato su un protagonista diverso. Scelta affascinante e operazione narrativa che sta portando avanti in maniera eccellente. Come ha scelto l’ordine “di apparizione” del protagonista di ciascun volume? Come è stato ed è per Lei calarsi ogni volta nel punto di vista narrativo di un personaggio diverso? Più “faticoso” o più “stimolante”?
Come ho sottolineato in precedenza, Malin era senza dubbio il personaggio che mi poneva dei vincoli. Mi interessava molto raccontarla nel suo periodo di intemperanze adolescenziali, ma non avrei potuto “aprire le danze” con lei, personaggio troppo respingente e ostico. Tuttavia, nemmeno potevo far passare la tempesta (intesa come i suoi anni problematici) senza mettere il focus su di lei. Mi è stato quindi subito chiaro che sarebbe stata la protagonista del secondo volume. Un volume problematico, perché Malin è il solo personaggio che, per ruolo, non può prendere direttamente parte a un’investigazione. Non avrei altrettanto potuto partire da Annelie, custode di un segreto che, in quanto tale, andava mantenuto almeno per due libri (divenuti poi tre). Ho dovuto quindi stabilire se presentare al pubblico prima Henning oppure Owe e alla fine l’ha spuntata lo spigoloso ufficiale della scientifica. La storia di Carola mi è stata chiara sin da subito, e altrettanto che Kaj avrebbe chiuso il cerchio. Ma mi conforta il fatto che, benché i sei personaggi si alternino e siano più o meno presenti nei vari libri, il loro contributo è sempre attivo e, spesso, fondamentale. Quanto alle varie difficoltà, essendo certamente meno vicino a Malin, moderatamente a Henning e molto di più a Owe, il mio impegno si è concentrato nell’accorciare le distanze con i personaggi più “difficili”. Una sfida, più che una fatica, ma anche un’applicazione ferrea per non perdere le caratteristiche principali di ciascun personaggio.
Una delle tematiche forti dei Suoi romanzi, che spicca soprattutto per gli effetti collaterali, è sicuramente quella legata all’abuso dei social e agli effetti mediatici che andranno, spesso, a trasformarsi in boomerang, sia nei confronti di apparentemente incolpevoli, ma anche verso chi sperava in qualcosa di diverso. Qual è il Suo rapporto con i social e perché ha scelto di dare questo taglio alle storie?
L’uso dei social è diventato più e più cruciale, anche per chi fa il mio mestiere. Personalmente non ho sperimentato il loro lato più oscuro, trovandoli invece uno strumento interessante di relazione con i lettori. Ma non mi sfugge che possano essere un terreno scivoloso, specchio di molti aspetti deteriori della società. Che i giovani siano più esposti agli effetti collaterali della frequentazione dei social è un fatto, ma l’analfabetismo digitale colpisce maggiormente gli adulti, e non va dimenticato. Il mio parere è che il loro sviluppo sia stato troppo rapido, eccessivamente diversificato e per nulla regolamentato. Avrebbe giovato una maggiore gradualità e, perché no, veicolarli anche negli ambienti scolastici e lavorativi. Del resto, sono entrambi luoghi che si fondano sulla socialità, e che dai social sono quasi completamente esclusi.
Nei Suoi romanzi si affrontano tematiche difficili e per nulla irrealistiche, purtroppo, correlate alla vita dei piccoli centri soffocati dall’isolamento, dall’assenza di stimoli e spesso dal bisogno di emergere, in un modo o nell’altro. Allo stesso modo, però, riesce ad alleggerire taluni momenti con una buona dose di ironia che spiazza, riuscendo a strappare una risata di pancia a chi sta leggendo. Qual è il Suo rapporto con l’umorismo? Fa parte più di Arwin J. Seaman o è anche una prerogativa di colui che si nasconde dietro questo pseudonimo?
Trovo che la vita sappia essere estremamente ironica e divertente, ancorché feroce. Ho imparato a cercare sovente il sorriso, strumento potentissimo in molti frangenti. Fa naturalmente parte di me e dei miei scritti, qualunque sia la firma che vi appongo, ma anche delle mie letture. Da Wodehouse a Benni, ho sempre amato l’umorismo sottile e intelligente. Nei limiti delle mie capacità, cerco di applicarlo in tutti gli ambiti dell’esistenza.
Quanti libri potremo aspettarci, ancora, prima di ritrovarci orfani di una serie che in un modo o nell’altro è riuscita a farci sentire a casa fra le sue pagine, nonostante l’apparente ostilità respingente dei luoghi e dei suoi diffidenti abitanti?
I libri previsti sono, e sono sempre stati, sei. Siamo a metà del viaggio, insomma, ora ci attendono Annelie, Carola e infine Kaj. Talvolta ho la tentazione di pensare a un settimo volume, che potrebbe chiamarsi: “Du côté de chez Andersson”, ma immagino sia una forma di autoconsolazione.
Lei racconta di storie ambientate nel Nord Europa, ma è anche un grande lettore di romanzi nordici? E in generale, quando smette la maschera da Arwin J. Seaman, quali sono i Suoi autori e generi di riferimento?
Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia di lettori. Avevo a mia completa disposizione classici italiani e stranieri, ma anche letteratura più leggera e contemporanea. Da qui la mia formazione, che mi vede oggi come fruitore curioso di molteplici generi, senza disprezzarne alcuno. Leggo con grande piacere i nordici, ma apprezzo anche i francesi, molto validi in questo genere, spagnoli e sudamericani. Amo Calvino come Gogol, Palahniuk come Agatha Christie, tra gli italiani contemporanei Ferrante e De Giovanni. Ma la lista è davvero lunga, mi considero un consumatore vorace, impossibile scegliere.
A cura di
Sabrina De Bastiani e Loredana Cescutti
Acquista su Amazon.it: